
« indietro
FINE DEL CANONE/NECESSITÀ DEL CANONE NELLA POESIA ITALIANA DEL PIENO NOVECENTO
di Daniele Piccini
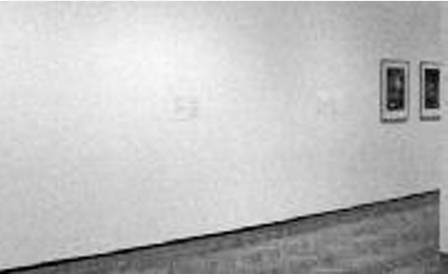
I. La poesia novecentesca e i suoi “problemi”
La ricerca poetica del Novecento italiano, e tanto più della sua parte finale, viene attraversata da una radicale messa in questione dello statuto stesso della forma espressiva: infatti, che cosa è poesia, dopo che le contestazioni e le innovazioni prodottesi a partire dalla metà dell’Ottocento circa e culminate con le avanguardie storiche (da noi almeno il Futurismo e in qualche modo il Crepuscolarismo) hanno dissolto la riconoscibilità formale, diciamo l’identità inconfondibile, dell’oggetto-poesia? La possibilità di scrivere in versi liberi, di fare a meno delle rime e delle forme metriche chiuse o di comporre ‘poemi in prosa’ e poi, con le avanguardie della seconda metà del secolo (ma il più era già stato tentato dal futurismo paroliberista), la contestazione della stessa comunicatività della lingua– con la creazione di collages, di testi privi di sintassi, desemantizzati– stendono, in particolare nello scorcio del secolo, un dubbio sull’identità della poesia e sulla sua stessa persistenza. Si può dire che tutti i tentativi di andare oltre la norma, di decostruire e destrutturare le regole e le forme di una tradizione tanto ricca quanto ingombrante siano state compiute. È come se sul secolo di poesia fosse corso un ininterrotto incendio, di cui negli ultimi decenni restano tracce di combustione insieme a cenere e sospensione.
Mai come nel XX secolo– non solo in Italia– è stato così profondamente sottoposto a critica il mestiere della scrittura poetica, del resto in analogia con tutte le altre forme d’arte. I poeti sono stati liberi, di una libertà totale e assoluta, che li ha costretti a rivedere dalle fondamenta il loro strumento e, in qualche modo, a verificarne ogni volta da capo–autore per autore, generazione per generazione la praticabilità. Si è dubitato a fondo, insomma, della pos sibilità stessa di fare ancora poesia (verteva su questo, non a caso, il discorso tenuto da Montale in occasione del ricevimento del Nobel nel 1975). Si è trattato di una poesia privata di sicurezze e garanzie, in cerca, prima ancora che di altro, della propria legittimità e forma. Ciò è coinciso con la definitiva perdita di un ruolo sociale e civile del poeta, se non quanto alla sostanza (cioè al significato possibile della sua voce nella polis), certo quanto a influenza e, come si dice, a audience. La revoca di una carta di identità, di uno statuto certo e autoevidente ha comportato una serie di conseguenze: 1) la pressoché definitiva eclissi di scuole e correnti dai forti legami interni e dalla indiscutibile consistenza; 2) l’acuirsi della pretesa conoscitiva della poesia, insomma il suo costituirsi, magari in una landa di desolata solitudine, come uno strumento di conoscenza totale, sostitutivo anche di altre discipline; 3) la maggiore difficoltà di individuare personalità indiscutibili e una apparente democratizzazione del genere, percepito come praticabile in forme fai-da-te da una larga fascia di scrittori amatoriali e dilettanti (alla lettera: che scrivono per diletto). Insieme a tutto questo, o come ultimo anello della catena, si è verificato un fenomeno storico di proporzioni prima impensabili: 4) la tendenziale sparizione della poesia dall’orizzonte culturale condiviso (quella dei curricula scolastici è di solito una poesia che si ferma ai maestri nati addirittura negli ultimi decenni dell’Ottocento: da Saba a Ungaretti e Montale).
Riprendendo uno per uno i punti accennati, possiamo dire che scuole e tendenze unitarie, esperienze vincolanti, correnti sono state quasi totalmente erose dallo smarrimento di una norma unitaria della scrittura: persi i contrassegni fondamentali della tradizione, la poesia è passibile di tanti sviluppi, sbocchi, esiti formali e stilistici quanti sono i suoi operatori. Se si possono individuare orientamenti di sensibilità e di cultura comuni (la ‘linea lombarda’, consistente in una poesia oggettivata di contro alla rarefazione lirica, ad esempio), è difficile che un movimento qualsiasi abbia reale compattezza e coesione. Sono le condizioni stesse del linguaggio usato che fanno della poesia del pieno Novecento una avventura individuale: ciascun poeta è, in qualche maniera, responsabilizzato a forgiarsi una sua lingua e una sua forma poetica [1]. Infatti, venuta meno la condivisione di un codice riconosciuto (una lingua speciale della poesia, letteraria e ben lontana dall’uso, come quella che giunge, per incrinarsi, fino agli autori a cavallo tra Otto e Novecento: da Carducci a D’Annunzio), mancando un novero di forme metriche e ancor prima lo stesso criterio della regolatezza metrica della poesia, perduto un orizzonte comune di presenza e di intervento e quindi un pubblico di riferimento, è giocoforza che ogni poeta sia chiamato a ritagliarsi una lingua, una forma, una sfida dialogica con un pubblico reale o immaginario. Anche Leopardi scriveva poesia in una solitudine culturale e civile notevolissima: tuttavia i tiranti dell’edificio della tradizione reggevano ancora alla sua altezza, tanto è vero che egli parte da forme riconosciute (la canzone ad esempio) per poi andare oltre ed è vero, soprattutto, che egli usa una lingua codificata circa cinque secoli prima dalla fondamentale esperienza lirica petrarchesca: una lingua che la comunità dei lettori-scrittori riconosceva. I poeti del pieno Novecento sono invece immersi in un fluire di frammenti, in uno stato collassato della tradizione e del linguaggio, in cui devono ogni volta far consistere, in forme instabili, la possibilità dell’espressione poetica, in assenza di coordinate accettate e comuni.
Questo, per venire al secondo punto, non è sempre e necessariamente un limite o un ostacolo. Accade infatti che, proprio dall’interno di questa inquisizione sul proprio essere e darsi, la poesia attinga a forme di consistenza e presenza forti, energiche, persino più vitali di quelle precedentemente sancite dalla tradizione (in cui la poesia si appoggiava, per solito, ad altre solide discipline: dalla filosofia alla teologia alla storia). La poesia, smarrita e in cerca di se stessa, paradossalmente formula l’ambizione di una conoscenza a tutto campo, priva di dati preesistenti. Si può assistere, insomma, al farsi di una scrittura poetica che si identifica con la stessa realtà: non con una sua descrizione o con una sua retorica celebrazione, ma con la stessa ontologia (l’atto di darsi, di essere delle cose). A questo proposito annotava Mario Luzi, uno dei maggiori poeti dell’intero secolo italiano, nella prefazione a una antologia di poesia novecentesca nel 1995: «Che cosa era reale in mezzo a tante appariscenze e a tanti residui di cosiddetta realtà? Nessuna vera fonte di certezza poteva venire a questo riguardo dalle dottrine correnti (…). Realtà era piuttosto questo brancolare alla ricerca della realtà; questo disagio di fronte alla improbabilità del presente, tuttavia tragico, era, contro ogni illusione del realismo teorico, la realtà» [2] (naturalmente Luzi allude implicitamente anche alle tragedie storiche che hanno costellato il Novecento facendo da detonatore delle nuove esigenze espressive e conoscitive).
Venendo al terzo punto, in tale fondativa libertà di orientamento e di ricerca, in assenza di parametri sicuri (dalla lingua codificata alla metrica, dalla retorica alla capacità narrativa o esplicativa di un testo), ecco che si impone per il lettore (e prima di lui per il critico, lo storico, lo studioso di cultura) il problema di discernere tra tante proposte quelle di valore indiscusso, tali da rappresentare, se non un orientamento paradigmatico e vincolante, almeno un’esperienza imprescindibile per tutta la comunità dei lettori e degli scrittori. Col che si assiste, oltre che al collassamento della tradizione e della forma della scrittura poetica, alla messa in questione della possibilità di una storia della poesia. Fino a giungere all’estremo per cui la civiltà contemporanea non riconosce (o, meglio ancora, non conosce) i suoi poeti, ed è magari propensa a rivestire dello statuto di poeticità forme altre e diverse, di solito più semplici e banalizzanti (come la canzone: ma il discorso sarebbe lungo) e comunque a non distinguere più il profilo della forma-poesia in mezzo a un’enorme offerta di prodotti di comunicazione e intrattenimento. All’altro capo del fenomeno sta la divulgazione di massa della pratica attiva (ma non della ricezione) della scrittura in versi: la rottura degli schemi e degli obblighi incentiva l’impressione di una relativa facilità dello scrivere poesie («non basta forse andare a capo?»), di solito producendo una quantità di prodotti amatoriali di scarsissimo rilievo, generati al di fuori di una qualsivoglia cultura poetica e di una inerenza alla tradizione del moderno e del contemporaneo.
II. Presenze e valori attraverso il secolo
Fissati questi punti, sarà bene dire subito che una poesia forte, capace di resistere alla mutazione e di ripensarsi, si è data per tutto il secolo, anche se con gradazioni di complessità e intensità variabili nel trascorrere delle generazioni. Cioè, come il secondo punto (potenzialità latenti di una poesia senza statuto preordinato) lascia intendere, il movimento non è stato di sola negazione, ma spesso anche di virtuosa ricostruzione, seppure– e ciò è fondamentale per l’intelligenza complessiva dei fenomeni– sempre in forme cangianti, sospese e compromesse con la crisi di sta tuto. Quello a cui si assiste avanzando nel secolo– cioè in una selva di negazioni e ipotetiche riedificazioni, di spinte e controspinte– è semmai la crescente difficoltà nella formazione di personalità centrali e assolutamente nevralgi che: insomma di quelli che per solito si riconoscono come i ‘classici’di un’epoca. Così può capitare che l’ultima parte del Novecento poetico italiano presenti come protagonisti, quanto a forza e peso specifico della produzione, poeti nati nei primi decenni del secolo e veda magari in maggiori ambasce o quanto meno in ristrettezze i poeti delle generazioni successive.
Vediamo, facendoci un poco più vicini all’oggetto specifico (che sono naturalmente gli autori e, ancor più propriamente, i testi) la misura e le ragioni di un simile fenomeno. È come se i grandi vecchi dell’ultima parte del Novecento, avendo attraversato un largo tratto dell’età della crisi e provenendo in origine da una cultura poetica ancora salda e spendibile, non così parcellizzata, fossero paradossalmente i più capaci di reinventare uno stile, di accordare la parola (le strutture ritmiche, retoriche, linguistiche) alle esigenze conoscitive del presente. Laddove poeti più giovani, maturati a valle di tanti rivolgimenti, di spute e fratture, e posti di fronte a maestri capaci di svariare in tutta la larghezza del campo, si trovano come inibiti e impediti nella costruzione di una voce piena, matura, organica. Il rischio esiziale, il più insidioso (che è in fondo naturale per chi viene dopo una tradizione ricca e anche in molti aspetti rovesciata e contestata) è, per i poeti attivi a partire dalla seconda metà del secolo e nel suo scorcio, quello di imitare, riprodurre, variare una delle maniere possibili sperimentate nel Novecento, di essere insomma epigoni di qualcuno piuttosto che centri propulsori di nuove possibilità espressive, di nuovi inizi della tradizione poetica. A questo rischio capita che siano meno soggetti, come si accennava, i poeti più maturi, coloro che hanno attraversato nelle sue fasi fondative la crisi e il tormento del secolo: così tra i poeti in assoluto più rilevanti del secondo Novecento saranno da annoverarsi almeno, oltre a Montale e Luzi, autori come Sereni, Caproni, Bertolucci, tutti nati ancora negli anni Dieci, cui si aggiunge (nato all’inizio del decennio successivo, nel 1921) Zanzotto.
È in effetti indubitabile che le maggiori personalità poetiche si siano formate nel corso della prima metà del secolo. C’è anzi tutto– per stare a una direttrice fondamentale, sebbene non sia certo l’unica–, una sorta di progresso nello scarto, una crescita ed evoluzione che va dalla contestazione futurista e in modo diverso crepuscolare per approdare al Montale degli Ossi di seppia (1925) e poi, in conseguenza, delle Occasioni (1939) e della Bufera e altro (1956).
Montale, non a caso autore di un decisivo saggio sull’autore, individua in Gozzano il primo poeta novecentesco che sia andato oltre D’Annunzio attraversandolo, cioè non limitandosi a negarlo, ma cercando una dialettica complessa, per essere, diciamo così, post-dannunziano senza essere necessariamente e schematicamente anti-dannunziano. La prospettiva di lettura montaliana ci permette di capire la sua (di Montale) esigenza: quella di una poesia non compromessa con la nota altisonante e recitatoria di D’Annunzio e di una larga fetta della tradizione, eppure capace di una sua eloquenza. Montale volle tirare il collo all’eloquenza, ma in modo da risuscitare nel discorso poetico una fermezza, autorevolezza, memorabilità degna di una controeloquenza (si vedano le affermazioni del poeta nell’Intervista immaginaria). È in fondo questo il ‘miracolo’ degli Ossi di seppia: una poesia che esce dall’ipoteca di una tradizione sentita come non più continuabile in forme meccaniche, ma anche dalle secche di una posizione eminentemente negativa e polemica, di abbassamento e smorzatura: una poesia che va oltre la linea maestra della tradizione poetica, senza tuttavia metterla in liquidazione. Basta prendere il testo d’apertura (dopo il vestibolo, costituito da In limine) degli Ossi, vale a dire I limoni, per rendersi conto di come l’autore porti oltre Gozzano il discorso ben gozzaniano di una poesia insieme critica e capace di una musica e un ritmo riconoscibili. La marcetta, la musicalità di Gozzano (e, a ritroso, tutte le soluzioni smorzanti di vari crepuscolari) è diventata una nuova forma di eloquenza, non altisonante né parodiata: un tono di maturità raggiunta (il che non esclude la doppiezza dei piani: Montale può dire di tenersi alla larga dai nomi e dalle cose propri dei poeti laureati, per coronarsi in realtà come ultimo, sia pure diverso, poeta laureato).
III. Una nuova poesia: linee e tensioni del secondo Novecento
III. Una nuova poesia: linee e tensioni del secondo Novecento
Con Saba, Ungaretti e soprattutto Montale (ma anche con altre personalità rilevantissime come almeno Dino Campana, i cui Canti Orfici escono nel 1914), la poesia italiana approda nei primi decenni del secolo a una sua voce ed espressione consapevole, già oltre– per la combinazione di elementi tradizionali o l’oltranza rispetto ad essi– i grandi modelli a cavallo tra fine Otto e primo Novecento: Carducci, D’Annunzio e Pascoli (l’ultimo dei quali senza dubbio addentro alla formazione della nuova temperie). Costituitisi questi autori primonovecenteschi come ‘classici’ (è il caso soprattutto di Montale da una parte e Ungaretti dall’altra, mentre il classico-popolareggiante Saba pare collocarsi in una posizione eccentrica, sebbene nutrirà una ricca linea alternativa che annovera almeno i nomi di Betocchi, Penna, Caproni e in parte Bertolucci), è chiaro che in qualche modo si ripresenta, complicato e ingorgato più di quanto non fosse in precedenza, il problema per i poeti successivi di trovare una lingua personale. Il primo Ungaretti (poi in forte evoluzione, con il recupero della metrica, della sintassi complessa e della retorica) e Montale hanno trovato una personale mistura, valida per se stessi, al problema della lingua di una nuova poesia novecentesca: ora si ripropone l’esigenza, in particolare rispetto a Montale, di ritrovare attraverso di lui, passando per lui, un’ulteriore compiutezza espressiva, che non sia subito ripetitiva e imitatoria; di adire insomma altre vie, pur tenendo conto delle acquisizioni precedenti. Parte almeno del nostro Novecento avrà il problema, insomma– come per Montale si trattò di attraversare D’Annunzio– di attraversare Montale per approdare ad altro senza liquidarlo. E non è operazione semplice, anche perché il poeta ligure va a toccare e ad occupare alcuni punti nevralgici della ideologia contemporanea, in particolare con l’atteggiamento della scepsi, della sospensione dubitativa del giudizio.
All’indomani della Seconda guerra mondiale, che ben più della Prima aveva mostrato le divisioni, contraddizioni e debolezze italiane ed era sfociata in una tragica e crudele guerra civile oltre che di Liberazione, la poesia di intonazione musicale leopardiana, astratta dall’agone del mondo e della storia, non poteva più essere proseguita, aveva in somma esaurito la sua produttività. Così Luzi con più decisione di altri ermetici (ma Bigongiari e Parronchi faranno altrettanto) recupera passo passo (raccolta di approdo fondamentale per una nuova maniera è Onore del vero del 1957) una lingua capace di aderire al travaglio della realtà e riattiva, al di sopra di quella petrarchesco-tassiana, la funzione Dante (come egli stesso chiarisce in un decisivo saggio del 1949, L’inferno e il limbo), che lo porta a una poesia drammatica, insieme intessuta di realismo e di aspirazione unificante, oltremondana (così i micro-racconti in finta-prosa di Nel magma, 1963 e 1966, sono scene insieme storiche e purgatoriali). Proseguendo in questa di rezione dantesca (ma di un Dante ‘triturato’in chiave ben novecentesca) Luzi approderà ai versi ampi, poematici quasi strutture esplose–, di Su fondamenti invisibili (1971) e alla stagione paradisiaca, della nominazione dell’unità divina del mondo letta attraverso la frammentazione e il divenire, stagione che prende corpo tra Per il battesimo dei nostri frammenti (1985) e Dottrina dell’estremo principiante (2004). Cellula germinale, iniziale di un lungo percorso attraverso linguaggi diversi, la poesia di estrazione ermetica non aveva in sé e per sé molte possibilità di prosecuzione nel nuovo clima, storico e linguistico: l’unico autore che ai suoi esordi può essere apparentato, nel maneggio della stoffa verbale, nella cura e nella duttilità smaterializzante dei sintagmi, a quella esperienza è (a parte l’isolatissimo Calogero) Andrea Zanzotto, che esordisce con Dietro il paesaggio (1951) e che svilupperà poi la natura tutta linguistica, febbrile e instabile di quella iniziale esperienza in direzione sperimentale, praticando una poesia che smantella i codici comunicativi e dà vita a una ipertrofia quasi tumorale delle cellule linguistiche, a una vitalità nevrotica, incontrollata e autonoma (da La beltà, fino alla trilogia costituita da Galateo in Bosco, Fosfeni e Idioma, 1978; ’83; ’86, e oltre).
Negli anni in cui Luzi rinnova a fondo il suo strumento, tutto l’ambiente circostante evolve nella medesima direzione: Vittorio Sereni (1912-1983), ai suoi esordi ancora vicino a una temperie ermetizzante e ormai capofila della «linea lombarda» (una poesia, dice il curatore della omonima antologia del 1952, Luciano Anceschi, in re e non ante rem, oggettiva e non puramente mentale), muove verso strutture micro-poematiche, con innesti narrativi, ragionativi e sociali (in cui comunque non vengono meno raffinate strutture retoriche e parallelismi ancora petrarcheschi), lavoro che sfocia nel 1965 nella pubblicazione della fondamentale raccolta Gli strumenti umani. In ambiente bolognese, la rivista «Officina» si fa banditrice di un nuovo sperimentalismo, non puramente formale ma che tenga conto della storia e del divenire storico: accanto a Roberto Roversi e Franceso Leonetti, c’è Pier Paolo Pasolini, che nel 1957 ha pubblicato Le ceneri di Gramsci e nel ’61 dà alle stampe il successivo La religione del mio tempo. Quello di Pasolini è un generosissimo tentativo di ridare sangue e polpa a una poesia ragionativa e civile, discorsiva, discettatrice, a tratti oratoria: una sorta di Vincenzo Monti o Carducci riletti attraverso il Pascoli. Pasolini, dopo aver tentato il felice e umbratile esperimento della poesia in friulano (Poesie a Casarsa è del 1942), recupera in modo duttile e solo approssimativo la forma chiusa della terzina (il metro, nel Novecento, dei Poemetti di Pascoli) per raccontare, attraversare e discutere le mutazioni antropologiche in corso (che inevitabilmente investono l’atto della poesia) nell’‘umile Italia’ post-contadina e ora industriale.
Con Pasolini, che lo aveva freddamente recensito eppure invitato a collaborare ad «Officina», intraprende una virulenta polemica Edoardo Sanguineti (1930), autore nel 1956 di un testo di algida e formalizzatissima sperimentazione, che mescola spezzoni di lingue morte (greco e la tino) e straniere all’italiano, in una babele di linguaggi, di ellissi, di spezzature sintattiche e logiche. Corifeo di quella che sarà la neo-avanguardia, resasi riconoscibile in forma collettiva con l’antologia I novissimi (1961 e 1965) e costituitasi poi nel Gruppo 63, Sanguineti postula una poesia fondata sul sabotaggio linguistico (facendo perno sul concetto marxista della equivalenza di linguaggio e ideologia) e d’altra parte si appoggia a una non comune e capillare conoscenza della poesia italiana (la sua tesi di laurea verte sullo sperimentalismo dantesco dell’Inferno, e non sarà un caso). Poi, a poco a poco, a partire più o meno da Postkarten (1975), andrà recuperando una funzione comunicativa, moderatamente narrativa seppure sempre febbricitante, citatoria, nevrotizzante, della poesia, continuando a mescolare parodia di generi e forme della poesia tradizionale (Sanguineti è il più post-moderno dei nostri poeti) a riattivazioni (più flebili negli ultimi anni) di una sua funzione politica e civile, sempre di contestazione. Nel complesso, la neo-avanguardia si costituisce in gruppo senza avere un vero collante comune (se non alcune idee guida, come la ‘riduzione dell’io’ e la poesia oggettivata, termini che avvicinano e saldano questa operazione ai fondamenti teorici della «linea lombarda» anceschiana): i più significativi autori presenti con Sanguineti ne I novissimi, cioè Antonio Porta ed Elio Pagliarani, hanno tempre e culture molto diverse e andranno, in parte dimostrandolo subito in parte nel tempo, in direzioni piuttosto distanti e disparate da quelle massimaliste sanguinetiane e dalla media linguistica (sabotativa e contestataria) della neoavanguardia: quella media che si costituisce, soltanto dopo l’antologia e i convegni del Gruppo 63, come un linguaggio comune per una larga pletora di imitatori.
IV. Fine del Novecento: quale strada?
IV. Fine del Novecento: quale strada?
Tra recuperi, sabotaggi, riappropriazioni e tagli obliqui, la poesia secondonovecentesca ha un profilo variegato e sfuggente. Nel quadro si inserisce, da nuovo protagonista ancora una volta, anche il vecchio Montale, che dopo un silenzio editoriale di quindici anni, pubblica nel 1971 (l’anno stesso della maturità di Bertolucci con Viaggio d’inverno oltre che del già ricordato Su fondamenti invisibili di Luzi) il suo nuovo libro, Satura, il cui titolo allude ad un genere latino fondato sulla mescolanza, la mescidazione, la medietà. È, in effetti, un libro del tutto nuovo rispetto al primo Montale, che prende atto di una situazione comunicativa, d’ambiente, del tutto mutata: c’è il sentore di ciò che al di fuori, oltre il recinto della letteratura, è diventato il mondo contemporaneo: del linguaggio delle gazzette (già irrise da Leopardi), dei nuovi media, del montante successo dell’intrattenimento e dell’omologazione culturale, sulla quale insiste fino alla tragica morte (1975) con ogni sua risorsa artistica e intellettuale Pier Paolo Pasolini. In buona misura Satura dissolve il primo Montale: insomma Montale va oltre se stesso, in un rovesciamento di prospettive che coinvolge l’istituzione tutta della letteratura. La maniera alta, a tratti cifrata e comunque sempre formalmente compatta e memorabile (seppure, come visto, magari antieloquente) praticata fin qui trova sbarrata la via dalla nuova barbarie– se così possiamo dire– di una società di massa che invera definitivamente l’allarme (risolto in gioco sardonico) lanciato all’inizio del secolo da Palazzeschi: «gli uomini non domandano più nulla / dai poeti». Che fare? Montale lavora di taglio e cucito, di calibrature e rimodulazioni, costruendo testi pieni di realia, di allusioni a luoghi, cose, persone (anche dimesse), elabora un verso andante, magari slabbrato, seppure ancora non così rilasciato, in cui entra di tutto (in Piove farà una parodia ‘alta’della dannunziana Pioggia nel pineto) e che pure è ancora capace di una sua forza di coesione. Ci sono interventi micro-retorici, ritmici, di intonazione che assicurano alla poesia, nell’atto in cui essa si adatta a un parlottio diffuso e a uno smantellamento di retoriche e forme tradizionali, una felicità e compiutezza espressiva, una evidente seppure compromissoria e duttile superiorità al piano del discorso comunicativo.
È, la poesia del secondo Novecento, attestata più o meno compattamente su una simile posizione? Non mi spingerei a dire tanto. Certo l’operazione montaliana, tanto più se letta in parallelo con la sperimentazione dell’avanguardia e con quella zanzottiana, con la nuova narratività di Luzi e Sereni, con la progressiva deriva informale dell’ultimo Pasolini (quello di Poesia in forma di rosa, 1964 e Trasumanar e organizzar, 1971), con la minuzia anche ironica di una poesia lombarda come quella di Erba, farebbe pensare a un minimo comun denominatore, se non altro tonale, magari in negativo (nel segno della liquidazione di una idea tradizionale più sostenuta). Una poesia che scende a patti col mondo e il linguaggio, che compromette la propria formalizzazione, la infiltra di elementi spuri. C’è, probabilmente, una direttrice storica di questo tipo (che naturalmente lascia aperto il campo a sperimentazioni eccentriche, isolate e di altro orientamento). Quello che certamente vale per quasi tutti è la definitiva consunzione di un codice separato, di una lingua speciale per la poesia, diversa e quasi opposta a quella dell’uso: pressoché tutti i poeti sulla scena nel secondo Novecento mediano, miscelano, innestano, ricorrendo da una parte al serbatoio della lingua letteraria, dall’altro a quello della lingua d’uso, tra forzature metrico-sintattiche e forzature del parlato: è senza dubbio questa la condizione di fondo, la condizione materiale e psicologica in cui tendenzialmente avviene il lavoro comune, e basterà pensare a nomi come quelli di Giudici e Raboni per capacitarsene. Ciò non significa anzi è l’opposto mancando una strumentazione condivisa– che si diano soluzioni ed esperimenti raggruppabili e coesi: di solito, fatte salve alcune scelte di campo fondamentali, è netto lo spicco individuale dei singoli tentativi.
Vale in qualche modo da controprova circa la difficoltà di trovare una lingua della poesia la straordinaria e in parte paradossale fortuna della poesia in dialetto (paradossale perché ha luogo mentre i dialetti come lingue parlate vanno scomparendo): si vuol dire che queste lingue marginali, meno usurate dalla letteratura e non raggiunte dalla banalizzazione comunicativo-mediatica dell’italiano standard, lingue ora preziose ora realissime ma comunque più prossime agli oggetti, alla loro nominazione, offrono ai poeti, a partire in particolare dagli anni Sessanta, uno strumento linguistico vitalissimo. Sono, le fondamentali esperienze in dialetto della seconda metà del secolo, ben diverse da quelle delle auctoritates dialettali ancora ottocentesche, come il Belli e il Porta, e in gran parte anche da quella già novecentesca di Tessa: lì c’era l’alternativa veristico espressionistica a un codice letterario, tendenzialmente aulico e vago, ancora ben in funzione; ora il dialetto assume le funzioni di una lingua integralmente costituita, non tanto diversa da una letteraria ancora in corso, quanto proprio una lingua totale, assoluta, capace di dire tutto, di esaurire in sé tutti i possibili confini di una cultura. L’italiano appare a volte sfatto e ‘di plastica’, a volte iper-letterario; il dialetto varrà allora, di volta in volta, come lingua lettera riamente preziosa ma meno usurata, o invece come lingua del vero o come contenitore aperto ad ogni sollecitazione, sia lirica sia espressionistica (si pensi a Franco Loi e Raffaello Baldini e in parte all’altro santarcangiolese Nino Pedretti). Insomma, la limitazione a suo tempo fissata da Pavese nel suo diario Il mestiere di vivere (in sé legittima, tanto più in una generazione ancora non troppo distante dall’unità) del dialetto come sotto-storia perde di valore per un periodo in cui alcuni dialetti, per lo più marginali e periferici, possono servire a riattivare funzioni che nella lingua sono diminuite e impoverite, insidiate o tendenzialmente collassate.
Se, come visto, gli autori già maturi proseguono la loro mossa ricerca attraversando il clima sperimentale della neo-avanguardia, gli autori nati a partire dagli anni Quaranta soffrono le inibizioni di una poetica negatrice e con testataria, i suoi diktat ideologici e non possono che cercare una propria via nella reazione a quelle chiusure. Capita che alcuni, transitando attraverso lo sperimentalismo, trovino poi la loro maniera più proverbiale in un recupero alto e solenne della funzione letteraria, col rischio, però, di ripetere grandi esperienze moderne o classicheggianti (si pensi al mito in Giuseppe Conte e in Roberto Mussapi). Alcuni ignorano pervicacemente il linguaggio medio dell’avanguardia e praticano una poesia informale, dal forte sapore romantico e decadente: è il caso di Dario Bellezza, debitore nei confronti dell’ultimo Pasolini ma meno dotato di lui di antidoti e contromisure. La linea lombarda ha una sua continuità, perché si tratta della poetica meno attaccabile dalle posizioni estreme dell’avanguardia, appoggiandosi ai mattoncini minimi degli oggetti e dei fatti e a una nervatura basilare e visiva del discorso (è il caso di Maurizio Cucchi e di Giampiero Neri, ad esempio). Proseguire su grandi filoni della modernità richiede una fortissima tempra linguistica, come nelle prove mature del toscano Alessandro Ceni, in cui si riversa l’asprezza dantesco-montaliana di una poesia dalla sonorità spessa, petrosa; oppure forti dosi di compromissione, ad esempio tra una visionarietà di ascendenza simbolista e una concretezza ‘lombarda’, come nel miglior Milo De Angelis, a partire da Somiglianze, del 1976: è chiaro che le generazioni post ’68 trovano un campo ingombro di macerie e di interdizioni e devono ricostruire in condizioni di difficoltà e di ricatto, mentre i grandi vecchi svariano e innovano appoggiandosi a una ricchissima esperienza personale e a un serbatoio di soluzioni storiche in loro ancora funzionale.
È, all’altezza di queste generazioni, impossibile discernere personalità forti, insomma canoniche? La vulgata critica italiana, a partire dall’antologia Il pubblico della poesia del 1975, di Alfonso Berardinelli e Franco Cordelli, va in questa direzione. Molte antologie successive sono elenchi, cataloghi di nomi in eccesso rispetto alle tavole fissate dalla storiografia poetica novecentesca fino a quel punto. L’impressione è che, insieme a una qualità media effettivamente non sempre così facile da giudicare e di scriminare, si faccia strada un indebolimento del senso storico dei critici, una difficoltà crescente a distinguere, giudicare e scommettere su alcune personalità. Trovo, tuttavia, che nel momento in cui la poesia perde autorevolezza e lettori e in cui moltissimi si improvvisano versificatori, il rischio di arrendersi all’enumerazione, al catalogo sia forte, perché contribuirebbe al definitivo col lasso di un’idea alta, ambiziosa, intellettualmente e artigianalmente decisiva di poesia (si pensa alla «gloria de la lingua» e al «miglior fabbro» danteschi). Del resto, se quanto detto sopra è veritiero, cioè il fatto che ogni poeta tardo-moderno si costituisce come uno snodo energetico di materia verbale, come un centro nervoso di nuove possibili idee di tradizione, non credo possibile ammettere che si diano centinaia di queste esperienze di rivitalizzazione del linguaggio. Un’idea non normativa né dogmatica di canone (idea su cui la storia letteraria si è sempre costruita, non avendo ciò niente a che vedere con le forzature e semplificazioni del “canone occidentale” di Bloom) mi sembra tornare necessaria, perché senza una ripartenza critica attorno a costellazioni di personalità messe in luce e trascelte nella ‘folla’ è difficile non cedere alla pura orizzontalità, lasciando magari che una storicizzazione surrettizia sia indotta per via puramente editoriale (a danno di personalità geograficamente marginali). Personalmente intorno a questa idea, di una selezione ancora possibile su base esclusi vamente linguistica e storica, ho costruito l’antologia La poesia italiana dal 1960 a oggi (BUR Rizzoli, 2005), abbastanza discussa in Italia, che conta solo 19 autori. Lo stesso tentativo di storicizzare mi pare possa indurre ad un affinamento dello sguardo, ad alzare la posta della riflessione: con la collaborazione degli studiosi (anche delle prossime generazioni) ho fiducia che si possano individuare e condividere delle presenze certe, a patto che si intenda uscire dalla vulgata della medietà e del livellamento. Voglio dire: una grande personalità si forma nelle fibre di una lingua quando le condizioni lo consentono, quando l’attesa e la necessità del ‘classico’ sono in atto. Non arrendersi alla quantità e alla media senza picchi, non cedere di fronte alla tentazione di un censimento puramente orizzontale mi sembra, da parte critica, un atteggiamento che può esso stesso contribuire a suscitare figure centrali, capaci di ripensare e riorientare la tradizione. In effetti, collocare tanti o tantissimi autori sullo stesso piano significherebbe, più che promuoverne molti, abbassare le punte più spiccate e significative, livellare verso il basso e contribuire, magari in modo involontario, alla definitiva entrata in crisi di una tradizione e quindi di un linguaggio, che appare oggi come uno degli ultimi in grado di sottrarsi alle tentazioni della banalità e della omologazione di massa.
NOTE
NOTE
1 Una ricognizione attraverso alcune delle principali ricerche di innovazione linguistica nella poesia novecentesca è tentata, a volo d’uccello, da Alberto Frattini, La sperimentazione linguistica nella poesia italiana dal primo Novecento agli anni Ottanta, in Id. (a cura di), Le problematiche dell’espressione e della comunicazione in prospettiva Duemila, Roma, Edizioni Studium 1990, pp. 37-102.
2 Mario Luzi, Osservazioni possibili su un secolo di poesia, prefazione a Poesia italiana del Novecento, a cura di Ermanno Krumm e Tiziano Rossi, Milano, Skira Editore 1995, pp. 12-13.
¬ top of page







