
« indietro
STORIE DI CANONE
di Franco Buffoni
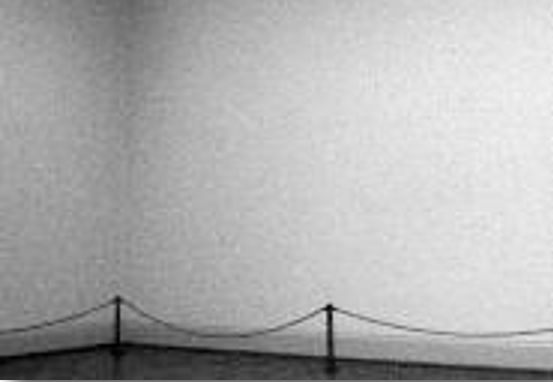
Parlavano di Otto-Novecento con tono competente i miei insegnanti delle scuole medie negli anni sessanta del secolo scorso. «Otto-Novecento» era il titolo di una rivista diretta da don Colombo della Cattolica di Milano (donde tutti loro provenivano); il nume tutelare era Mario Apollonio. Ebbene, oltre alla triade Foscolo-Manzoni-Leopardi di già desanctisiana memoria, ci venivano inculcate, come formule chimiche o prodotti notevoli algebrici, altre, più recenti triadi: Carducci-Pascoli-D’Annunzio, e modernissima: Ungaretti-Montale-Quasimodo.
In seguito, all’università, Aldo Borlenghi, ottimo professore ormai a fine carriera, amico di Ugo Guandalini e del gruppo storico parmense della prima Fenice (Macrì, Luzi, Pietrino Bianchi, Bertolucci) faticò non poco a di struggere quegli schemi: a un autore italiano veniva asse gnato il premio Nobel per la letteratura? Si elogiava un elzeviro intitolato A caval donato non si guarda in bocca (Emilio Cecchi). Borlenghi, tuttavia, non ebbe la forza e il tempo di inculcarmi nuovi schemi. Riuscì solo a farmi demolire i vecchi.
Così negli anni settanta mi affacciai alla vita adulta e alla letteratura con in testa la convinzione che distruggere gli schemi fosse sempre impresa proba e meritoria. Si doveva anche diffidare ‘dei grandi poteri personali’, dei ‘sistematori’ interessati, dei clan.
Negli anni seguenti mi si chiarì quali fossero le due ‘M’ portanti da attaccare. Non la P2, ma la M2. Moravia e Montale erano, nelle due situazioni geografiche di Roma e di Milano, nelle due antipodiche condizioni caratteriali, nei due diversi generi letterari… erano i detentori del potere letterario da scardinare.
Ormai si era agli anni Ottanta; grazie alla nuova Fenice ‘milanese’ diretta da Raboni con Cucchi redattore, avevo avuto i miei esordi come poeta nel 1979 (in uno dei Quaderni Collettivi con Nell’acqua degli occhi) e come traduttore nel 1980 (Sleep and Poetry di John Keats). E proprio da Raboni– dapprima solo in privato– quindi sempre più apertamente in articoli e interventi pubblici, vidi mettere in pratica quanto mi era stato insegnato. In modo scientifico, direi. Fu la più programmata, sapiente, lavorazione ai fianchi di un mito consolidato (da fare impallidire gli attacchi a Eliot in Inghilterra) a cui mai nel Novecento fu dato di assistere in Europa. E il veicolo principale– per suprema beffa– fu poi proprio quel «Corriere della sera» che per decenni aveva visto imperare lo ‘gnomo’ di via Bigli. Tale divenne Montale, grazie anche a tre ‘fiancheggiatori’ di tutto rispetto: Baldacci, Garboli e Mengaldo.
Raboni anteponeva da par suo Rebora a Montale? Baldacci replicava che Betocchi era il più grande poeta del Novecento italiano (ma senza contraddire Raboni, sempre e solo a scapito di Montale). Raboni– mentre sacrosanta mente cercava di fare ‘passare’ Delio Tessa almeno sul piano nazionale– attaccava di nuovo Montale? Garboli replicava con un paradossalmente tonante «Sandro Penna è il più grande del Novecento» (della serie: se lirica la poe sia ha da essere…), ma senza contraddire Raboni: sempre e solo a scapito di Montale.
Si giunge così alla fine degli anni Novanta con un risultato che cercai– come è nel mio temperamento– di volgere al positivo. Lo scrissi in un saggio intitolato Rilettura del secolo in poesia che apparve nel 1999 nel volume L’Italia, oggi, a cura di Laura Lepri e Roberto Fedi per le edizioni Guerra, dal quale estraggo il seguente passo: «Nell’ultimo decennio, da parte di molti critici, è andata sempre più accentuandosi la tendenza– già manifesta nel decennio precedente– a ribaltare l’idea che al centro del Novecento poetico italiano vi sia la linea ermetico-avanguardistica con l’assoluta preminenza estetica di Ungaretti e Montale. Sullo stesso piano di Montale– e, per alcuni critici, persino al di sopra di lui– è ormai unanimemente considerato Umberto Saba. E poeti come Camillo Sbarbaro, Delio Tessa, Clemente Rebora vengono sempre più rivalutati a scapito naturalmente di Montale. Mentre di Ungaretti si parla meno, e di Quasimodo si preferisce tacere. Le inequivocabili affermazioni di critici come Baldacci e Garboli– che rispettivamente hanno configurato in Betocchi e Penna il poeta italiano più grande del Novecento (naturalmente sempre a scapito di Montale)– ci permettono ormai di definire chiusa la polemica tra Novecento e Anti-Novecento, cioè tra il versante in luce (con Ungaretti, Montale, gli ermetici, Luzi) e il versante ex in ombra della tradizione anti-Novecento, con Palazzeschi, Govoni, Saba, Diego Valeri, Penna, Caproni. I due versanti– ormai sono entrambi in luce».
Una situazione critico-ideologica che Franco Fortini aveva fotografato con lucidità già nel 1977 introducendo i suoi Poeti del Novecento: «Fare corrispondere le novità o la diversità della poesia contemporanea alla prima raccolta di Ungaretti significa accettare quella che dal 1925 al 1945 parve una linea sicuramente privilegiata che condurrebbe dai vociani agli ermetici; mettere invece in rilievo Gozzano (o Lucini) e i futuristi (o Palazzeschi e Govoni) si gnifica contestarla, quella linea, e identificarne una di rottura…».
Fuori discussione che, a radicalizzare lo scontro, a per mettere a Fortini di operare una sintesi tanto efficace, e forse– pur se indirettamente– a indurre anche noi oggi a discutere ancora di canone, sia stata la pietra aguzza gettata nello stagno della critica italiana da Sanguinati nel 1969 con la sua Poesia italiana del Novecento. Lì, nel paragrafo nitidamente intitolato al verso libero, l’autore di Bisbidis contesta il contestatore. Dribblando astutamente il suo maestro Luciano Anceschi che, in posizione dominante, aveva posto Campana, Sanguineti mette sotto i riflettori la figura di Lucini. Senza quel precedente, otto anni dopo, Fortini non lo avrebbe nemmeno menzionato, e oggi sarebbero davvero ancora in pochi a conoscerlo.
Credo che la portata dell’imposizione di Lucini da parte di Sanguineti sia dirompente almeno quanto la successiva ‘lavorazione ai fianchi’ di Montale da parte di Raboni. Adimostrazione del fatto che il canone uno ci prova a crearlo: si tratta poi di capire quanto altri lo prendano sul serio.
Quella che sto cercando di delineare è certamente una situazione estrema, con la guerra personale senza quartiere, l’attacco a tutto campo. Sanguineti che– deliberatamente– esclude dal suo canone Bertolucci, Fortini, Zanzotto, Giudici e, naturalmente, lo stesso Raboni (esaltando– per contro– Balestrini: in questo subdolamente fingendo di adeguarsi all’equilibrato canone anceschiano); Raboni (e Giudici: nel 1983 in giuria al Viareggio) che umiliano l’avversario, propiziando la vittoria del giovane Maurizio Cucchi al Premio Viareggio del 1983– con la memorabile plaquette Glenn edita da San Marco dei Giustiniani– vs. Edoardo Sanguineti con l’opera omnia apparsa da Feltrinelli.
Una casa editrice importante– Feltrinelli– un maestro come Anceschi, una acuta intelligenza critica dispiegata sui classici con occhio attento alle istanze internazionali (si pensi al Dante di Sanguineti filtrato dalla lettura modernista di Pound e Eliot): basta tutto questo perché si possa riuscire a imporre un proprio canone?
Che cosa occorre per imporre un canone? Il canone è una regola imposta da una autorità. Tale autorità può imporre la propria regola cercando di uniformare istanze già ampiamente condivise; oppure– ed è il caso più difficile, più pericoloso, ma anche più ‘vincente’ in caso riuscita può provocare, contraddire, cercando di imporre una propria visione nuova e originale. È quanto fu tentato da Sanguineti con l’operazione-Lucini e– paradossalmente anche dal suo avversario Raboni con la demolizione di Montale.
Poiché in ambito letterario non esiste l’elezione a vita di un pontefice (malgrado certe situazioni tendano graziosamente ad assomigliare a un pontificato: Cecchi, Contini, Mengaldo...), l’autorità che impone la regola è sempre e inevitabilmente sottoposta a verifiche. Dunque il tempo, le antologie, gli studi critici incrociati, la pazienza di biografi e filologi, il gusto dei lettori e quant’altro stabiliranno (o hanno già stabilito) che Lucini non è un grande poeta e che il grande poeta rimane Campana. Che Tessa, Rebora, Sbarbaro, Betocchi, Penna sono certamente dei grandi poeti, ma che Montale rimane il più grande del Novecento italiano.
Tre coetanei: Mengaldo, Sanguineti e Raboni. Un grande maestro sullo sfondo: Anceschi. Credo che una sintesi tecnica della riflessione sul canone possa essere impostata su questi quattro nomi. Il fatto che due– Sanguineti e Raboni– siano (o siano stati) anche poeti di primo piano fa subito risaltare la forzatura della loro presenza anche come critici, in particolare come stabilizzatori di canone. Ma tant’è.
Se più che legittima mi pare la– peraltro elegante contestazione che Mengaldo mette in atto nei confronti dell’assunto anceschiano in base al quale eredi dei Lirici Nuovi dello stesso Anceschi sono i Novissimi di Giuliani (e Mengaldo lo dice già nel 1971, in un saggio che poi appare in Tradizione del Novecento. Prima serie, 1975; e lo ribadisce nella introduzione ai suoi Poeti italiani del Novecento), molto più strumentali a un personale interesse in quanto autori ci paiono le posizioni di Sanguineti e Raboni.
Irrilevante– al confronto– il fatto che Mengaldo attacchi Anceschi. Quello con Anceschi è un normale di scorso tra critici accademici. Di Anceschi non si può non approvare la genialità dell’intuizione critica nel definire Sereni, la formidabile impostazione neo-fenomenologica in funzione anticrociana, l’enorme opera di scavo critico compiuta con «il Verri». Siamo sempre dentro i limiti del l’auspicabile, del desiderabile. Decisamente fuori da questi limiti ci troviamo invece con Sanguineti e con Raboni.
In questa ottica risulta persino accessoria, non determinante, l’oggettiva alleanza tra Mengaldo e Raboni in funzione anti-sanguinetiana, o l’attacco di Mengaldo a Sanguineti eAnceschi insieme. In sostanza voglio dire che se Sanguineti e Raboni non avessero usato il loro potere accademico, giornalistico e editoriale per promuovere la propria immagine di autori costruendosi un canone ad hoc, il dibattito sarebbe stato più onesto e più chiaro.
Se la dovevano vedere tra loro Mengaldo e Anceschi. Ed eventualmente se la doveva vedere Baldacci con Guglielmi e Barilli. I poeti coltivino la loro poetica, se è genuina; i critici facciano il loro mestiere in fecondo dialogo con i poeti; e i filosofi dell’estetica tornino olimpicamente a giudicare e a pontificare sui frutti di tale dialogo, rendendo operante forse, domani, anche un canone.
Rimane pur vero che se siamo qui noi italiani a parlare del nostro canone a Nuova York una ragione c’è. E si tratta di una motivazione che in Italia verrà sentita tra qualche decennio; quando anche da noi saranno penetrate nel tessuto critico-accademico istanze di cultura femminista, etnica, omosessuale, atea; quelle stesse che negli Stati Uniti portarono– nell’ultimo quarto del secolo scorso– a contestare radicalmente gli «iniqui strumenti di oppressione delle minoranze» rappresentati dai cosiddetti core curriculum courses (obbligatori per gli studenti di tutte le facoltà), che proprio da qui, dall’autorità della Columbia University, irradiavano la loro regola su tutto il continente Nord Americano e anche oltre. Particolarmente contestato il corso di Literature Humanities, che da Omero a Shakespeare a T.S. Eliot stabiliva il canone occidentale, maschile, bianco, eurocentrico. I famosi dead white european males. Una posizione che venne irrisa con virulenza da Roger Kimball nel 1990 col suo feroce Tenured Radicals (Contestatori di ruolo) e che altrove venne definita ‘Scuola del Risentimento’. Un canone poi strenuamente difeso con le armi dell’intelligenza e della pacatezza da Harold Bloom nel suo Canone occidentale (1994).
Se può essere di interesse l’esplicitazione di una posizione personale, confesso che negli anni Ottanta fu per me una vera boccata di ossigeno leggere Bloom. E Steiner. Da giovane accademico mi trovavo compresso tra istanze critiche di impostazione lacaniana, decostruzionista e poststrutturalista. La lettura, per esempio, di After Babel e di Real Presences fu per me magistrale: si poteva ancora parlare– in letteratura e in poesia– di uomini e di donne, di sentimenti… Naturalmente non pensai mai, né penso tuttora, di disconoscere i meriti dei formalismi primo novecenteschi, anzi me ne avvalgo a piene mani; tuttavia cerco sempre di coniugarli a istanze di segno estetico. Se si perde il baricentro rispetto alla kantiana ‘dottrina del gusto’, qualunque eccesso e qualunque arbitrio possono più facilmente prevalere. E forse– se ci riflettiamo con occhio estraneo e distanziato– molti dei guai che stiamo denunciando e di cui siamo anche personalemte vittime è proprio dovuto al fatto che alla naturale triade composta da estetica, critica, poetica è andata sostituendosi negli ultimi decenni, con la messa in discussione delle poetiche, una pericolosa dialettica tra critica e teoria della letteratura. Sono ancora convinto che se la poetica– come si desume dalla limpida sintesi anceschiana– consiste nella «riflessione che gli artisti e i poeti compiono sul loro fare, indicandone i sistemi tecnici, le norme operative, le moralità e gli ideali», essa inevitabilmente si fortifica ponendosi in fecondo dialogo con la critica; e anche che entrambe– critica e poetica– per sentirsi definite e forse divenire un giorno un possibile oggetto di canone– debbano essere congiuntamente contemplate dal filosofo dell’estetica: il solo in grado di trarre la sintesi, di cogliere il senso profondo, di quel dialogo.
Quell’operazione di interpretazione e di fraintendimento che un poeta successore mette in atto nei confronti del predecessore, tanto ben descritta da Harold Bloom, io mi permetto ancora di definirla ‘poetica’. Non è certo l’assoluta originalità di un’opera letteraria a garantirne l’entrata in un ipotetico canone. Assoluta originalità per altro concettualmente non concepibile se non nei termini dell’assoluta incomunicabilità. Letteratura nasce da letteratura e poesia nasce da poesia. Che cosa rende la letteratura originale, fresca, innovativa ed– eventualmente– degna di canone? La risposta non può che riguardare l’esistenza o meno di una genuina ‘poetica’.
In altri termini non ha molto senso prendersela con Montale per avere rielaborato all’interno dei propri, alcuni versi di Clemente Rebora. O rintracciare nei Mottetti inequivocabili stilemi penniani. Ciò che conta è se quegli elementi hanno quagliato all’interno della poetica montaliana producendo poesia, o se sono restati meri plagi o al più citazioni.
Un vero artista non copia, ruba, sosteneva Picasso. Altra è la riflessione etica. E proprio con riferimento a Montale vorrei esprimerla senza ambiguità. Mentre sostengo che la poetica di Montale è talmente profonda da potersi permettere di inglobare brandelli di versi di predecessori e di contemporanei senza venirne intaccata, anzi uscendone irrobustita, con altrettanta convinzione mi sento di affermare che fu senza scrupoli e spietata la rapacità montaliana nel nutrire anche di versi altrui la propria poesia. Montale era convinto che di Rebora– autosepoltosi in convento dai rosminiani– non si sarebbe parlato più, che sarebbe stato dimenticato; altrimenti non avrebbe osato, non se lo sarebbe permesso. Egualmente, Montale era certo che il nome di Penna non sarebbe mai ‘passato’: censura fascista, che egli stesso metteva in atto preventivamente, omofobia raggiunta come traguardo intellettuale dopo i giovanili turbamenti… La questione, però, a mio avviso, non riguarda la poetica e non riguarda il canone: è solo drammaticamente, squisitamente, etica.
Si tratta dello stesso meccanismo che– in sedicesimo– indusse il De Angelis di Terra del viso ad avvalersi dei dattiloscritti di allora giovani autori fino a provocare il noto scandalo. Ma credo che nessuno se la senta di affermare che la poetica di De Angelis non sia stata in grado di digerire quegli innesti, facendoli propri.
Credo sia persino superfluo chiedersi chi siano– oggi–Anceschi e Mengaldo, Raboni e Sanguineti.
Che molti «cce stiano a provà» mi pare fuori discussione. Ma chi riuscirà a raggiungere la quieta saggezza del professor Anceschi, nutrita di dottrina e di dedizione alla riflessione sull’arte? E l’autorevolezza di Mengaldo? Quando–emiècapitato più volte negli scorsi due decenni– mi imbatto in un giovane particolarmente dotato nella speculazione critica e nell’approfondimento di tipo estetico, e cerco di incoraggiarlo, magari facendogli pubblicare la tesi di dottorato o facendolo partecipare a un im portante convegno, sempre– inevitabilmente– implacabile come una reazione chimica, mi giunge il suo fascio di versi in proprio. Bellini, costruitini, con le due varianti dei ‘parenti morti’ o dello ‘sperimentalismo’ a seconda che l’obiettivo sia ‘lo specchio’ o ‘la bianca’. Anche i più intelligenti non sembrano in grado di capire una realtà elementare: come critico avresti un futuro, autorevole, serio; posto naturalmente che tu ti voglia impegnare fino in fondo, con onestà di intenti e adeguata strumentazione. Perché non prendere Anceschi o Mengaldo come modello? No, vedi il lampo sibillino negli occhi, il giovane vuole tutto: le muse e il sofà.I modelli sono Sanguineti e Raboni.
E chi sono oggi Sanguineti e Raboni? Mi sembra evidente che della disinvoltura e dell’ambizione di Sanguineti e di Raboni siano dotati in tantissimi, che scrivono versi in proprio e che– con o senza copertura accademica– cercano– ciascuno con una propria ottica di gruppo o di tendenza– ponendo se stesso o il sodale più stretto in posizione di caposcuola (salvo poi pentirsi, trasformando detto ex sodale nel nemico più bieco)– di accreditare se stessi in posizione sicura, inoppugnabile, nel futuro e definitivo canone della poesia italiana del nuovo secolo. Posseggono cinismo, disinvoltura e ambizione. Impressionante è la costante regressione ad età quasi scolare della messa in atto di tali comportamenti: incominciano subito, prima del primo capello bianco. L’unica cosa che interessa loro è il canone, il potere, la costituzione di un baluardo inattaccabile. Anche perché– a parità di cinismo, disinvoltura e ambizione– è ben difficile rintracciare in loro lo spessore culturale e le capacità poetiche di Raboni e Sanguineti.
Quanto più genuini, paradossalmente, mi appaiono i comportamenti dei loro coetanei narratori, preoccupati di tirature e di contratti, di percentuali sui diritti! Non esistendo per i critici-poetini la voce “mercato”, esiste unicamente il potere: l’antologia, la rivista, la critica addomesticata… E non si rendono conto di avere già completamente prosciugato– a trent’anni– qualunque vera curiosità sugli uomini e sul mondo, di avere inaridito definitivamente quella minima fonte di poetica che era in loro nell’adolescenza. Però hanno pronta la loro mappa generazionale!
Quanto più genuini, paradossalmente, mi appaiono i comportamenti dei loro coetanei narratori, preoccupati di tirature e di contratti, di percentuali sui diritti! Non esistendo per i critici-poetini la voce “mercato”, esiste unicamente il potere: l’antologia, la rivista, la critica addomesticata… E non si rendono conto di avere già completamente prosciugato– a trent’anni– qualunque vera curiosità sugli uomini e sul mondo, di avere inaridito definitivamente quella minima fonte di poetica che era in loro nell’adolescenza. Però hanno pronta la loro mappa generazionale!
Mappe generazionali che– come qualunque persona sensata comprende– sono redigibili solo a posteriori, molto a posteriori! Costoro invece si comportano come se bastasse conoscersi a trent’anni per decidere di essere una nuova generazione poetica! Quanta superficialità, quanta ingenuità mista ad arroganza! Il discorso sulle generazioni, tanto autorevolmente e con cautela avviato nella prima metà del secolo scorso, mi pare oggi letteralmente dege nerato. O forse si crede che, comportandosi da coscritti, si possa davvero costruire un canone? Laddove dovrebbero essere evidenti almeno due considerazioni:
- ‘generazione’non significa avere trent’anni insieme, bensì giungere insieme a un certo grado di maturazione poetica. E la maturazione poetica non procede anagraficamente. Vi sono poeti che– come Rimbaud– danno il meglio di sé a vent’anni; altri che– come Wallace Stevens maturano molto più lentamente, e solo a sessant’anni riescono a scrivere il loro capolavoro.
- se costruirsi una poetica solida, convincente, riconoscibile e duratura è ardua impresa di una vita, costruirla ‘di gruppo’ è impresa quasi disperata. La facilità con cui costoro parlano di ‘canone’e di ‘poetica di gruppo’è grottesca, ingenua, commovente.
Mi pare invece condivisibile la terminologia alla quale fecero ricorso una diecina di anni fa (1999) Trevi, Perrella e Onofri, con la sostituzione– mutuata da Benjamin– del termine ‘costellazione’al termine ‘canone’. Nella convinzione che– come scrive Onofri (Il canone letterario, Laterza 2001, pp 45-6)–«se i testi (le stelle) rappresentano i dati oggettivi d’una costellazione, resta sempre vero che le linee di raccordo tra quelle stelle, le linee che le organizzano in disegno (la costellazione, per l’appunto), sono sempre stabilite dall’interprete».
¬ top of page






