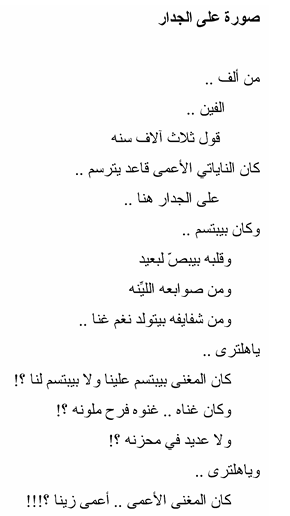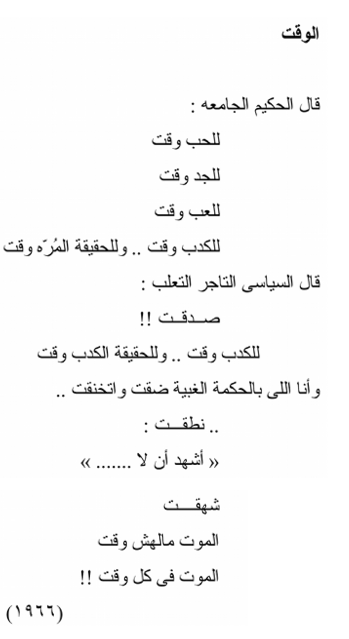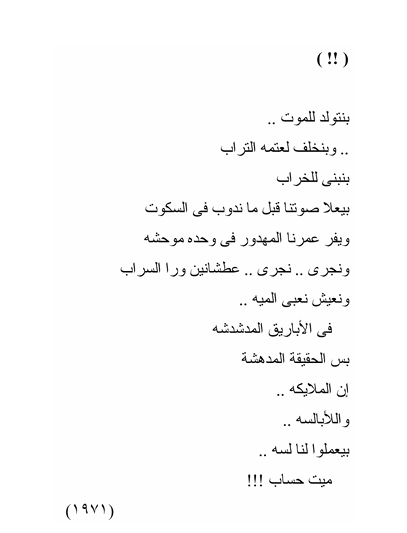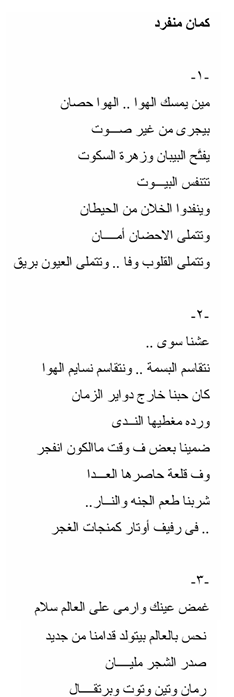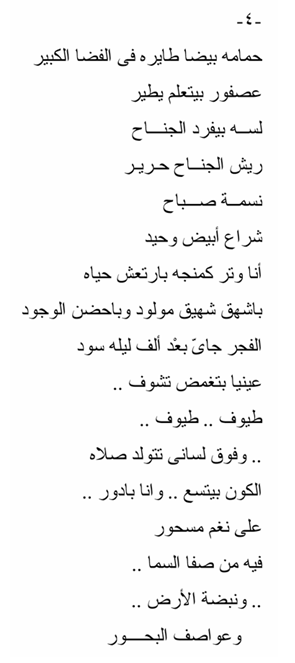|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Saggi e testi online |
|
|
|
|
|
| Visits since 10 July '98 |
|
      
|
|
|
|
« indietro
SAYED HEGAB
a cura di Fulvia De Luca
Sayed Hegab è una figura decisamente atipica nel panorama della poesia egiziana contemporanea. La poesia ‘canonica’ ha un riferimento costante nei grandi classici, in Egitto Ahmad Shawqi (1868-1932) e Salah ‘Abd al-Sabur (1931-1981), e negli straordinari esiti linguistici e stilistici che hanno conseguito in una lingua, l’arabo classico, tanto sensibile alla vocalità poetica quanto esposta alla minaccia costante di innaturalezza e distanza rispetto al mondo dei lettori. Per Hegab la questione della lingua è stata, ed è, centrale. Nato nel 1940 in un piccolo paese, al-Matariya, sulle sponde del lago Manzala, sin dalle prime esperienze di vita (e quindi di poesia) ha avuto come ‘umanità’ di riferimento l’universo dei pescatori del suo villaggio e come matrice dell’immaginario la dizione orale delle epopee arabe dei Banu Hilal, delle Storie di ‘Antara e di Baybars. E dopo una prima fase di produzione in lingua classica, in conformità alla formazione accademica che in quegli anni acquisiva, negli anni ’60 Hegab sceglieva il dialetto, pur trasfondendovi i movimenti di rima e ritmo dell’arabo classico. Nel 1966, la sua prima importante raccolta Sayyad wa ginniya (‘Un pesca tore e una jinn [1]’) conquistava il plauso della critica, in Egitto sempre diffidente nei confronti dell’utilizzo del dialetto in funzione letteraria; alcuni critici lo paragonarono a Lorca, altri a Éluard, e tutti intravidero nel poeta una fulgente promessa della poesia egiziana. Invece, fu l’inizio di un silenzio poetico durato vent’anni. Hegab afferma di aver preso atto di un paradosso: i pescatori del suo villaggio, i soggetti che rappresentava e che avevano ispirato i suoi versi, dovevano in qualche misura parteci pare al suo messaggio. Invece il suo libro a loro non è mai arrivato: il tasso d’analfabetismo all’epoca era altissimo. Ha deciso di non pubblicare più e di ‘usare la voce’ con la gente; vale a dire di diventare un qawwal, il poeta del la tradizione orale. Del resto la parola shi‘r [ar., ‘poesia’] trova la sua genesi nella dimensione dell’oralità, nella recitazione in versi. E il Kitab al-Aghani [2] è appunto il ‘Libro dei Canti’, la cui denominazione sottolinea una componente vocale preminente sulla scrittura.
Il suo contributo alla società della cultura egiziana, certo, non fu interrotto. Nel 1968 Hegab fondava con altri intellettuali la rivista Gallery 68, che vantava personalità come Ibrahim Arslan, Edwar al-Kharrat, Muhammad al-Busati: il proposito dichiarato della pubblicazione era il rinnovamento della poesia e della letteratura egiziana (che, secondo Hegab, «in quel periodo risentiva ancora dei vincoli dell’estetica gadanoviana»). Per due anni visse all’estero, in Svizzera e in Francia, per poi in Egitto sotto la spinta di un sentimento di estraneità e sradicamento dal suo popolo [3].
Il cinema, la TV e la radio gli hanno aperto quel corridoio mediatico di massa che una volta in Egitto era dominio dei cantori che recitavano le antiche storie popolari nei caffè accompagnandosi con la rababa [4]. Ha scritto molte canzoni per film, per produzioni televisive, per rappresentazioni teatrali. Ha anche tradotto L’Opera da tre soldi di Brecht in arabo e scritto i testi di canzoni egizia ne di successo. E il suo dilemma è sempre stato: come affrontare temi profondi, essere latore di un messaggio definito e semplice senza essere semplicistico?
La soluzione è talvolta l’adozione della forma della poesia in fiaba/fiaba in poesia. La struttura è lineare; Hegab in genere si serve di un personaggio tipico o del dialogo tra due o più interlocutori, di natura diversa (ad esempio uomini, animali o jinn) e portatori di differenti valori, secondo la matrice fedro-esopiana. La poesia sviluppa riflessioni su temi universali (il senso della vita e della morte, la vanità dell’esistenza, la ricerca del vero) senza sfiorare mai luogo comune se non nel senso di quel lo spazio ideale condiviso dall’umanità intera, in bilico tra l’essere e il non-essere. Lo sguardo del poeta è disincantato; la sua voce si sovrappone a quella del Qohelet, in un difficile esilio dall’involucro transeunte della vita. L’uso del dialetto in questo contesto può sembrare straniante, dissonante, eccessivo; per comprendere appieno questa scelta dobbiamo però affidargli il suo significato più concreto, di lingua madre che veicola i sensi primi dell’esistenza in antitesi al modo mediato e opaco delle costruzioni successive del mondo/linguaggio acquisito (in questo caso dell’arabo classico). È notevole, dunque, il risultato in ter mini di carica mimetica, d’imitazione della parola detta, che così il testo acquisisce e che abbrevia la distanza tra mittente e destinatario del messaggio.
Nel breve saggio qui riportato, ci siamo divertiti a tentare per due poesie la trasposizione in dialetto romanesco, quasi ad accostarlo ad un’altra grande voce, quella di Trilussa, che fece la stessa scelta linguistica e rivelò in alcune composizioni lo stesso sentire del nostro poeta [5]. Si tratta di un libero adattamento, che tuttavia ci sembra fedelissimo allo spirito delle poesie.
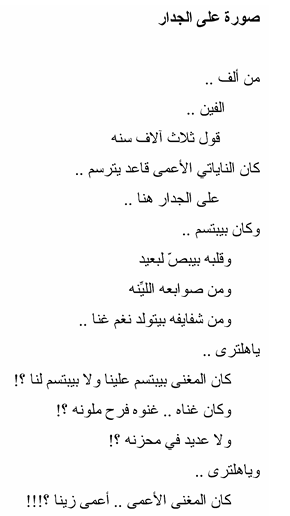 |
IMMAGINE SULLA PARETE
Da mille...
duemila...
forse tremila anni...
il flautista cieco sta sempre a mostrar se stesso sulla parete... qui
e ci sorride spesso...
col cuore guarda lontano
e dalle dita leggere,
dalle labbra genera la melodia d’un canto.
Mi chiedo
A noi sorride o ci deride?
E la sua melodia... è un allegro canto
o è invece lutto e pianto?
Allora mi chiedo:
se il suonatore cieco... è come noi, cieco.
1969
|
L’IMMAGGINE SUR MURO
Sta lì sur muro
forse da millanni
da dumila... chissà!
famo tremila...
Su la parete se mostra senza inganni
a noi che innanzi je passamo ‘n fila.
Puro si è ceco lui guarda lontano
move le dita e ‘ntanto piano piano
dar flauto sembra j’esca fora ‘n canto
e che sorida ar pubbrico frattanto.
Ma a guardà mejo no, nun è ‘n soriso
vedo er sarcasmo impresso ner suo viso
e forse nun è canto quer che sento
che dar suo flauto scenne drent’ar core...
Adesso so’ sicuro... è ‘n gran dolore
e er sòno che se sente è solo ‘n pianto
e nun è ceco... ce vede er sonatore! |
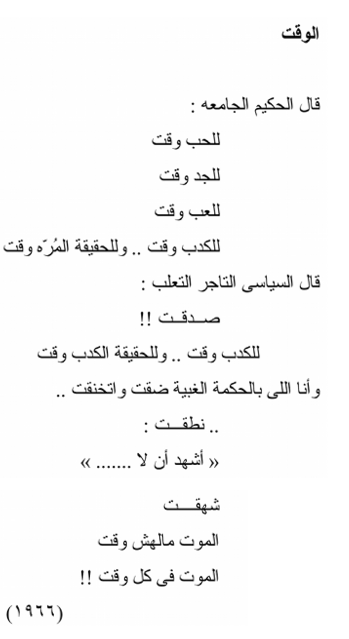 |
IL TEMPO
Qohelet disse:
C’è un tempo per l’amore
un tempo per la serietà
un tempo per il gioco
un tempo per la menzogna... un tempo per l’amara verità
Disse la volpe, politico e mercante:
Hai ragione!
C’è un tempo per mentire... e un tempo per la verità mendace
e io che nella sciocca saggezza sono costretto e soffocato
Dissi:
«Credo ad un solo Dio...»
E singhiozzavo
La morte non ha tempo
la morte è di ogni tempo.
1966
|
ER TEMPO
Er Saggio disse: «C’è un tempo pe’ l’amore
Uno pel gioco o pe’ la serietà
Uno pe’ la bucia der mentitore
E n’artro pe’ l’amara verità.»
La vorpe dipromatica e affarista
Disse: «C’hai raggione! C’è un tempo per mentire
E ce n’è nartro in cui te conviè dire
‘na verità buciarda e opportunista.»
Oppresso e schiavo della mia saggezza
Me so’ rivorto cor pensiero a Dio
E singhiozzanno ‘n fonno ar core mio
Ho ritrovato un’unica certezza:
«Tutto c’ha un tempo, meno che la morte.
Lei getta i dadi pe’ tirà la sorte.
Doppo de che giunge tra noi furtiva.
Qual è er suo tempo?... Quello quanno ariva!!» ( !! ) |
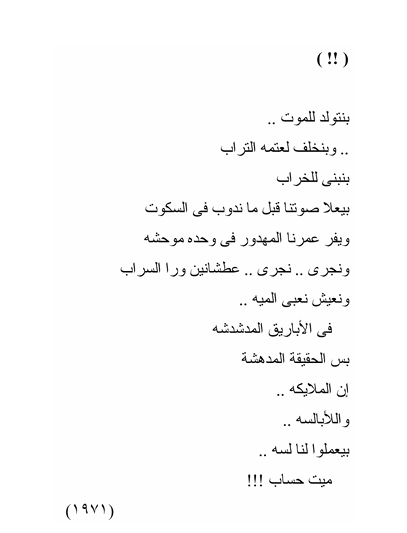 |
(!!)
Nasciamo per morire...
... generiamo per il buio della terra
costruiamo per distruggere
e la voce alziamoprima di svanire in silenzio
la vita scorre sbattuta nella più selvaggia solitudine
e noi corriamo... assetati dietro un miraggio
e viviamo per colmare d’acqua
brocche frantumate
Ma la verità stupefacente
è che angeli...
e demoni...
hanno ancora per noi...
mille attenzioni
1971 |
Nella poesia che segue, il tono riflessivo-sapienziale viene messo in secondo piano a favore di una modulazione lirica del tutto diversa, che si abbandona alla visione e alla descrizione dell’universo intimo. La lingua segue l’esito del diverso piano figurativo: ora è la lingua classica a prevalere; del dialetto non resta che una pallida eco.
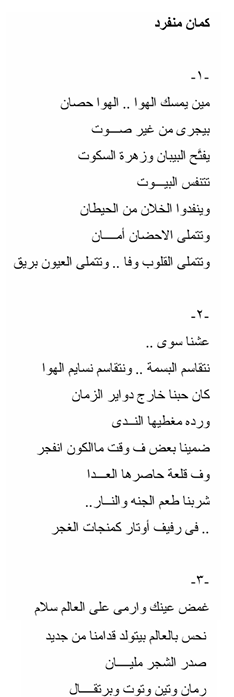 |
ANCORA SOLO
1 -
Chi afferra l’aria... l’aria è cavallo
che corre senza voce
schiude le porte e il fiore del silenzio
dà respiro alle case
gli amici passano per le pareti
di pace si riempie il petto
di fede il cuore... di lampi gli occhi
2 -
Siamo vissuti insieme...
dividendo il sorriso e il soffio della brezza
il nostro amore era al di là del tempo
una rosa madida di rugiada
Ci siamo uniti all’esplodere dell’universo
In una rocca assediata da nemici
Bevemmo l’inferno e il paradiso...
... nel vibrare delle corde dei violini gitani
3 -
Chiudi gli occhi e manda un saluto al mondo
che nasce di nuovo davanti a noi
e il ventre dell’albero è colmo
di melograni, fichi, gelsi e arance. |
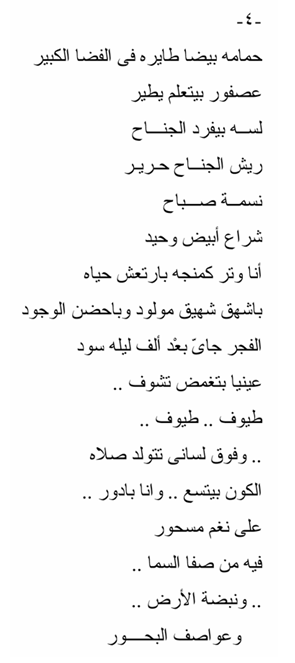 |
4 -
Una colomba bianca vola per l’immenso spazio
Un passero impara a volare
quasi non stende le ali
dalle piume setose.
La brezza del mattino
una bianca vela solitaria
sono corda di violino che vibra di vita
piango come neonato e abbraccio il mondo.
L’alba arriva dopo mille notti nere
Chiudo gli occhi per vedere...
Ombre... ombre...
alle labbra affiora una preghiera
L’universo si espande... ed io nel vortice
di magiche melodie nella purezza del cielo
e nel fremito della terra
nelle tempeste del mare. |
(traduzioni dall’arabo di Fulvia De Luca; trasposizioni in roma nesco di Gabriella Massa)
NOTE 1 I jinn sono gli spiriti folletti della tradizione islamica, esseri intermedi tra gli uomini e gli angeli.
2 Il florilegio più famoso della poesia classica, raccolto nel X secolo dal persiano al-Isfahani (897-967).
3 “Pensai: «Che ci faccio qui? Come posso scrivere per gli egiziani? Sto vivendo l’umanità nella diversità». Decisi di tornare, di smetterla di essere un traditore. Ho scritto ad un amico: «Gli uomini sono alberi o uccelli. Io voglio essere un albero». Con i suoi rami”.
4 Strumento ad arco tradizionale diffuso in tutto il Medio Oriente, con una piccola cassa di risonanza, da cui sembra derivata la nostra ribeca.
5 Come esempio di questa vicinanza ideale tra i due poeti ci tiamo la chiusura de La bolla de’ sapone: «So’ bella, sì, ma duro troppo poco./ La vita mia, che nasce per un gioco / come la mag gior parte de le cose,/ sta chiusa in una goccia... Tutto quanto / fi nisce in una lagrima de pianto».
¬ top of page
|
|
| Iniziative |
|
|
11 gennaio 2026
Addio a Giancarlo Cauteruccio
11 dicembre 2025
Convegno Compalit, Pisa 11-13/12/25: Filtri. La forma come mediazione e come conflitto
5 dicembre 2025
Semicerchio a "Più libri più liberi" (Roma)
3 dicembre 2025
Dialogo con Jorie Graham-Torino
12 ottobre 2025
Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi
9 ottobre 2025
Addio a Francesco Recami
26 settembre 2025
Semicerchio a Bright -Siena
22 settembre 2025
Adesione sciopero per Gaza
21 settembre 2025
Semicerchio col CRIC a Firenze RiVista
9 settembre 2025
In memoria di Anna Maria Volpini - Firenze, 9 settembre
1 settembre 2025
Per i 90 anni di Charles Wright - di Antonella Francini
7 giugno 2025
Semicerchio per Gaza
26 marzo 2025
Semicerchio a UNISTRASI
5 marzo 2025
Il testo-natura. Presentazione di Semicerchio 70 e 71, Roma Sapienza.
22 novembre 2024
Recensibili per marzo 2025
19 settembre 2024
Il saluto del Direttore Francesco Stella
19 settembre 2024
Biblioteca Lettere Firenze: Mostra copertine Semicerchio e letture primi 70 volumi
16 settembre 2024
Guida alla mostra delle copertine, rassegna stampa web, video 25 anni
21 aprile 2024
Addio ad Anna Maria Volpini
9 dicembre 2023
Semicerchio in dibattito a "Più libri più liberi"
15 ottobre 2023
Semicerchio al Salon de la Revue di Parigi
30 settembre 2023
Il saggio sulla Compagnia delle Poete presentato a Viareggio
11 settembre 2023
Recensibili 2023
11 settembre 2023
Presentazione di Semicerchio sulle traduzioni di Zanzotto
26 giugno 2023
Dante cinese e coreano, Dante spagnolo e francese, Dante disegnato
21 giugno 2023
Tandem. Dialoghi poetici a Bibliotecanova
6 maggio 2023
Blog sulla traduzione
9 gennaio 2023
Addio a Charles Simic
9 dicembre 2022
Semicerchio a "Più libri più liberi", Roma
15 ottobre 2022
Hodoeporica al Salon de la Revue di Parigi
13 maggio 2022
Carteggio Ripellino-Holan su Semicerchio. Roma 13 maggio
26 ottobre 2021
Nuovo premio ai traduttori di "Semicerchio"
16 ottobre 2021
Immaginare Dante. Università di Siena, 21 ottobre
11 ottobre 2021
La Divina Commedia nelle lingue orientali
8 ottobre 2021
Dante: riletture e traduzioni in lingua romanza. Firenze, Institut Français
21 settembre 2021
HODOEPORICA al Festival "Voci lontane Voci sorelle"
11 giugno 2021
Laboratorio Poesia in prosa
4 giugno 2021
Antologie europee di poesia giovane
28 maggio 2021
Le riviste in tempo di pandemia
28 maggio 2021
De Francesco: Laboratorio di traduzione da poesia barocca
21 maggio 2021
Jhumpa Lahiri intervistata da Antonella Francini
11 maggio 2021
Hodoeporica. Presentazione di "Semicerchio" 63 su Youtube
7 maggio 2021
Jorie Graham a dialogo con la sua traduttrice italiana
23 aprile 2021
La poesia di Franco Buffoni in spagnolo
22 marzo 2021
Scuola aperta di Semicerchio aprile-giugno 2021
19 giugno 2020
Poesia russa: incontro finale del Virtual Lab di Semicerchio
1 giugno 2020
Call for papers: Semicerchio 63 "Gli ospiti del caso"
30 aprile 2020
Laboratori digitali della Scuola Semicerchio
» Archivio
|
|
|
|
 |
|
»
»
»
»
»
»
»
»
»
|
|
|
|
|
|
|
|
| Editore |
|
|
|
|
| Distributore |
|
|
|
|
Semicerchio è pubblicata col patrocinio del Dipartimento di Teoria e Documentazione delle Tradizioni Culturali dell'Università di Siena viale Cittadini 33, 52100 Arezzo, tel. +39-0575.926314, fax +39-0575.926312
|
|
web design: Gianni Cicali

|
|
|
|